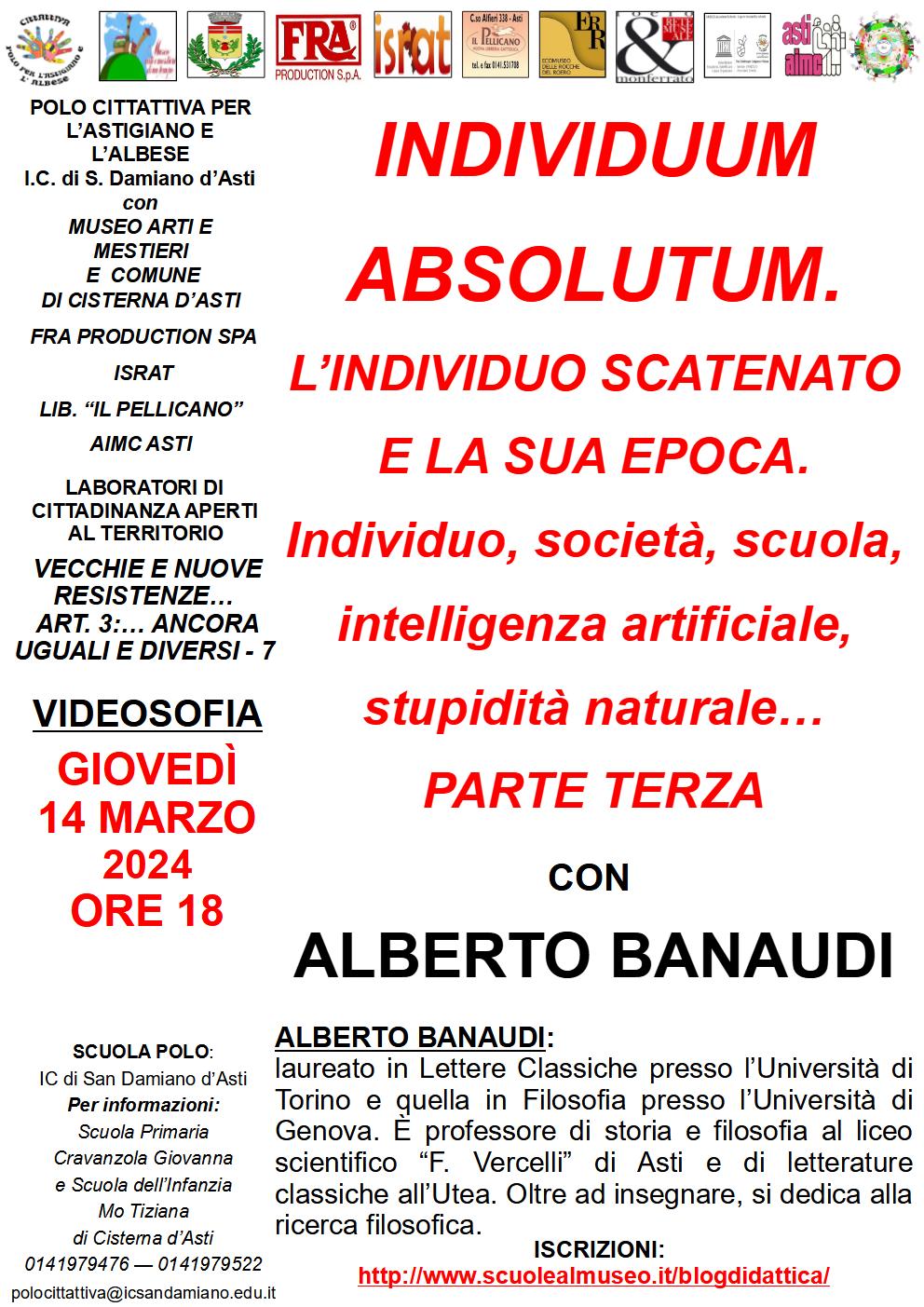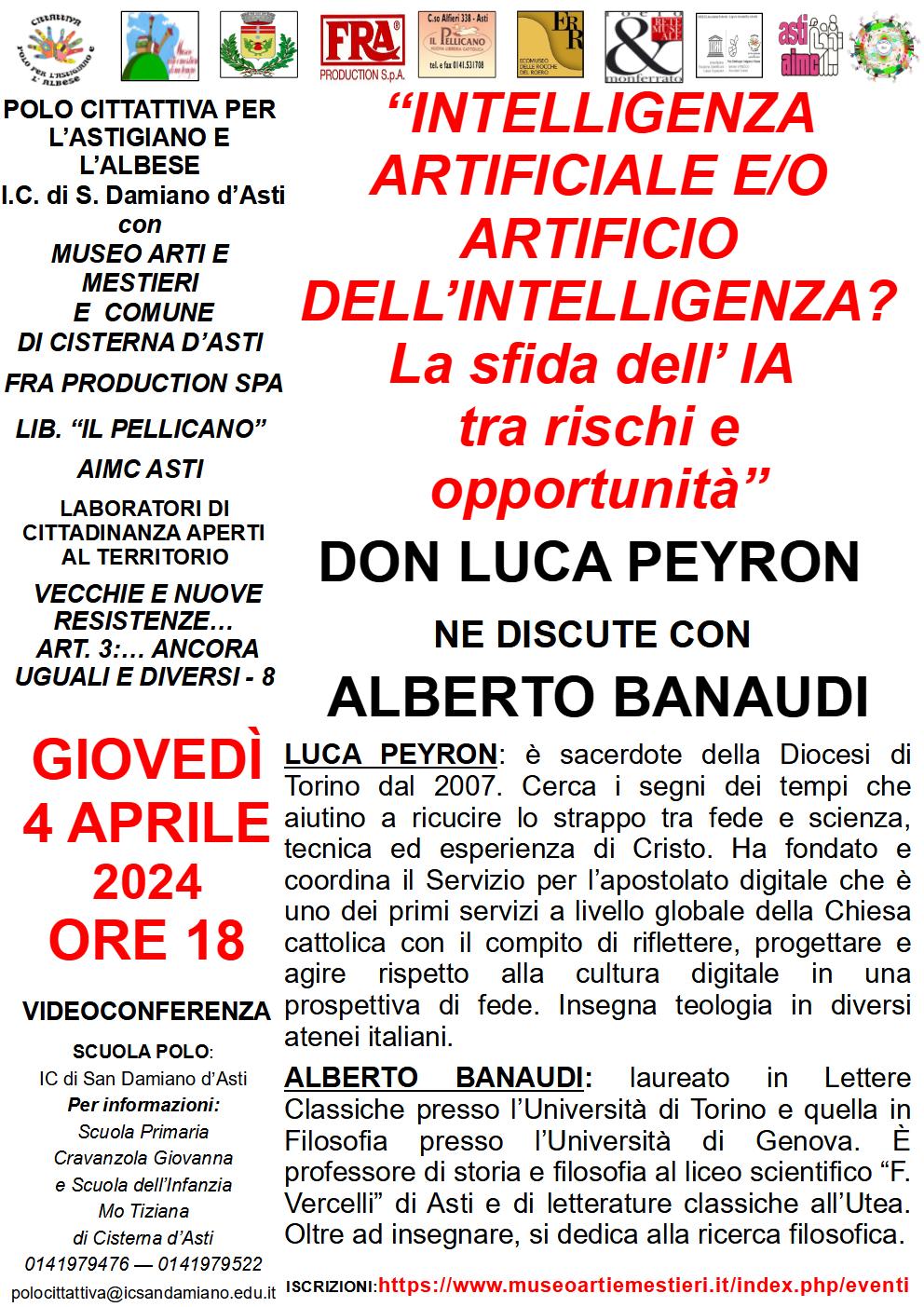
Articoli per le parola chiave » Alberto Banaudi «
Giovedì 15 febbraio 2024 in videoconferenza (Meet) si è tenuta la seconda videosofia con il prof. Alberto Banaudi dal titolo “Individuum absolutum. l’individuo scatenato e la sua epoca. individuo, società, scuola, intelligenza artificiale, stupidità naturale… parte seconda“. L’iniziativa, inserita all’interno del percorso more…
“Individuum absolutum. L’individuo scatenato e la sua epoca. Individuo, società, scuola, intelligenza artificiale, stupidità naturale…” è il titolo della nuova videosofia che si è tenuta giovedì 16 novembre 2023 con il prof. Alberto Banaudi. L’iniziativa, inserita all’interno del percorso “Vecchie e nuove R-esistenze_Art. 3: … ancora uguali e diversi_3” è stata more…
Nella società della comunicazione, spesso ci sono malintesi reciproci. La nostra vita quotidiana ne è costellata e, a volte, determina anche la rottura di relazioni di diversa natura. Di more…
“L’enigma dei due Papi. Uno sguardo sulla delicata situazione della Chiesa Cattolica contemporanea. Parte III. Benedetto XVI: Traditionis custos” è il titolo della terza videostoria che si è tenuta giovedì 23 Febbraio 2023 con il prof. Alberto Banaudi .
L’ iniziativa è stata promossa da Polo Cittattiva per l’ Astigiano e l’ Albese – I.C. di S. Damiano, Museo Arti e Mestieri di un Tempo e more…
Prima videostoria del 2023 con il prof. Banaudi. Sì è tenuta il 26 gennaio 2023, il secondo appuntamento di un ciclo di incontri dedicato alla Chiesa cattolica attuale. Titolo dell’ incontro “L’enigma dei due Papi. Uno sguardo sulla delicata situazione della Chiesa Cattolica contemporanea. Parte II: La Chiesa e il mondo”. L’ iniziativa è promossa da Polo Cittattiva per l’ Astigiano e l’ Albese – I.C. more…

Giovedì 27 ottobre 2022, sono ripresi gli incontri con il prof. Alberto Banaudi. L’iniziativa, inserita all’interno del percorso “Vecchie e nuove R-esistenze_Art. 3: uguali e diversi_3” è stata organizzata da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano con Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna con Fra Production Spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti. Per l’anno in corso, il professore ha scelto di dedicarsi alla storia. La prima videostoria dal titolo “L’enigma dei due Papi. Uno sguardo sulla chiesa cattolica contemporanea” ha inaugurato un percorso impegnativo ma anche originale che verrà declinato anche nei prossimi mesi.
“La scelta di parlare di questo tema, parte da uno sguardo sulla delicata situazione delle chiesa more…
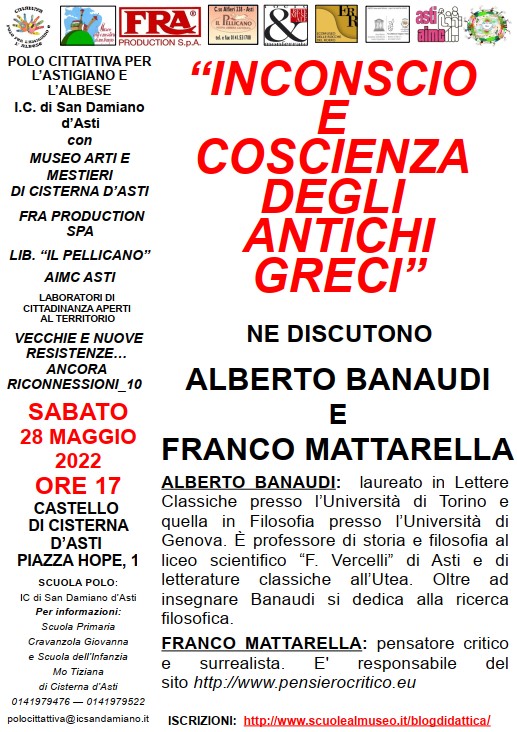
Finalmente, dal novembre 2019, sabato 28 maggio 2022 sono ripresi gli incontri filosofici al castello di Cisterna d’Asti. Per l’occasione, Alberto Banaudi e Franco Mattarella hanno discusso di “Inconscio e coscienza degli antichi greci”. L’incontro, inserito nel percorso“Vecchie e nuove R_esistenze:.. Ancora Riconnessioni_10”, è stato promosso da Polo Cittattiva per l’ Astigiano e l’ Albese – I.C. di San Damiano, Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna con Fra Production Spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti.
Franco Mattarella, che ha aperto l’incontro, ha iniziato parlando dell’ inconscio come di ciò che ha permesso agli esseri viventi di sopravvivere specialmente nelle situazioni di pericolo nelle quali non c’era tempo di decidere ma anche oggi scegliamo allo stesso modo. more…
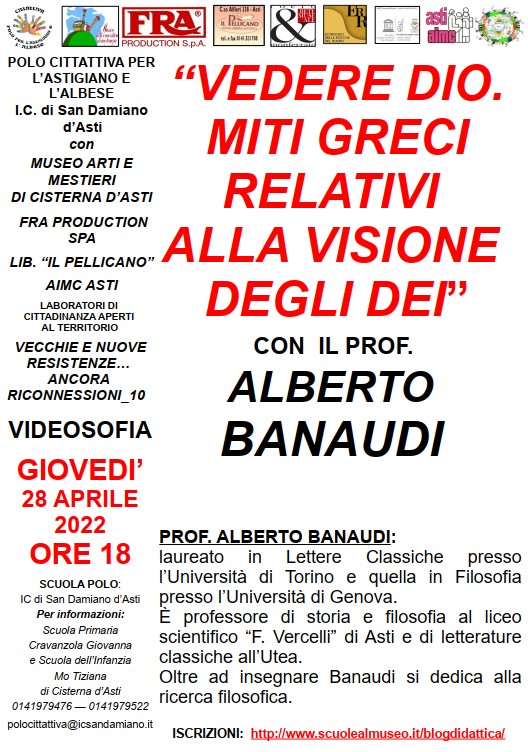
Proseguono gli incontri con il prof. Alberto Banaudi che, giovedì 28 aprile 2022 alle 18, è ritornato con una nuova videosofia dal titolo“Vedere dio. Miti greci relativi alla visione degli dei”. L’iniziativa è stata promossa da Polo Cittattiva per l’ Astigiano e l’ Albese – I.C. di San Damiano, Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna con Fra Production Spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti. Cosa significava, nel mondo greco, stare di fronte alle divinità? Vedere il divino, in tutte le culture, rappresentava qualcosa di particolare e, a volte, anche di pericoloso. Ciò che era sacro doveva essere tenuto separato per non essere contaminato e non doveva neppure interferire con le culture umane. Tutto ciò valeva anche per i greci? I popoli orientali avevano approccio diverso rispetto a loro. All’uomo biblico, l’effetto dell’incontro con Dio suscitava il timore. Chi vedeva Dio non poteva vedere Dio. Tutto ciò è stato un grande oggetto per tutte le religioni: da un lato la paura ma, dall’altro, la ricerca dell’ incontro. Ad esempio nell’Apocalisse, c’è la rivelazione di Dio. L’Apostolo Giovanni, esiliato sull’isola di Patmos, scrive un libro per tutti i dissidenti del mondo per dire loro che devono avere fiducia perché porta con sé la speranza che gli ha dato Gesù. Rivelare, dire svelare ma anche ri-velarlo (cioè velarlo) di nuovo. Dio non si può mai vedere fino in more…


 Parole chiave:
Parole chiave: